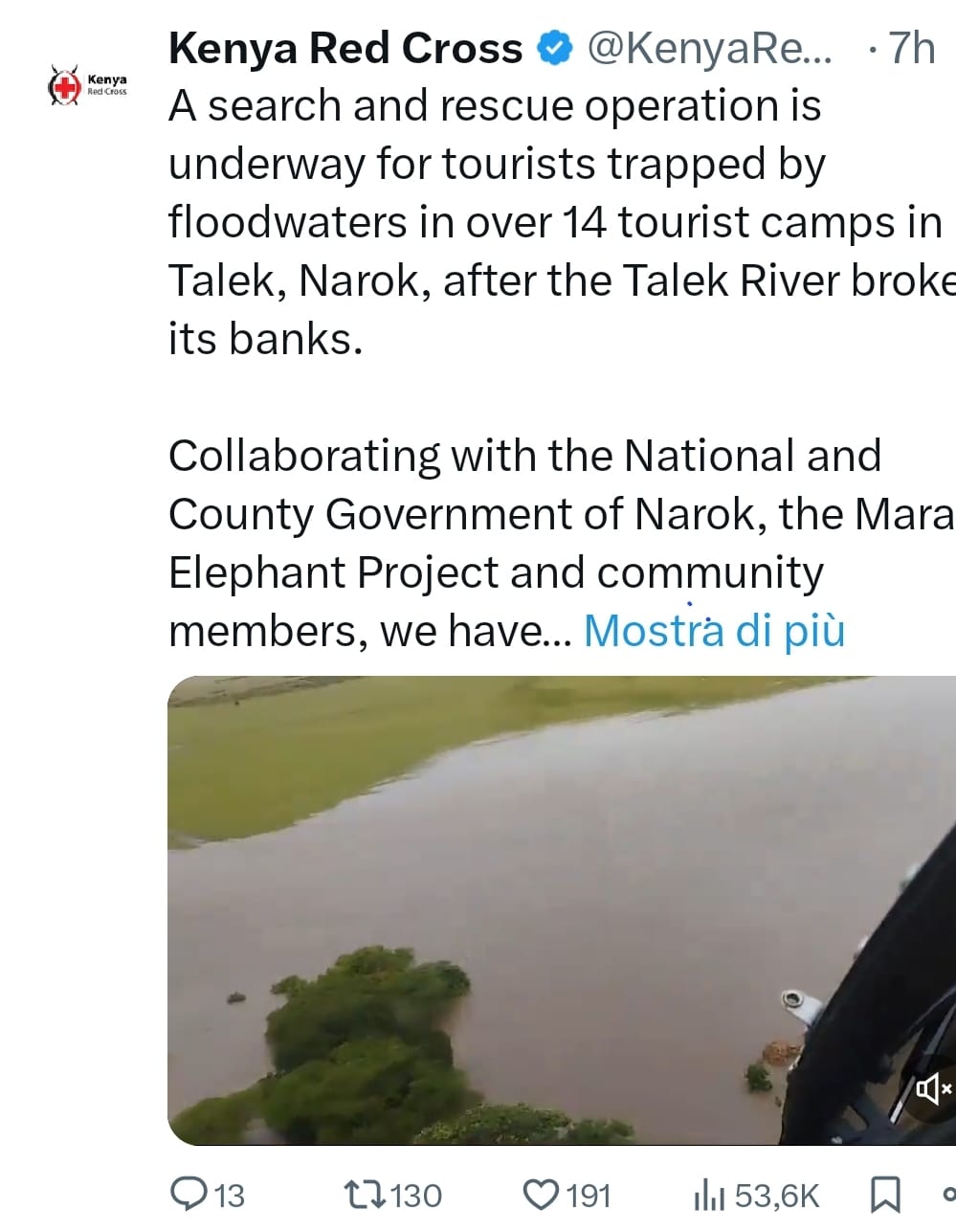EDITORIALE
EDITORIALE
Eric Salerno
9 maggio 2024
L’altro giorno nella email ho trovato questa segnalazione del New York Times: “Gli attivisti studenteschi filo-palestinesi, che hanno allestito accampamenti nei campus di tutto il Paese, affermano che il loro movimento è anti-sionista ma non antisemita.” E subito sotto: “Juan Arredondo per il New York Times: Non è una distinzione accettata da tutti”. Ancora prima di avere il tempo di leggere l’articolo è arrivata una dichiarazione del premier israeliano Netanyahu: “Un’indagine della Corte Penale Internazionale su Israele sarebbe puro antisemitismo”. E ancora: “La Corte istituita per prevenire atrocità come l’Olocausto nazista contro gli ebrei ora prende di mira l’unico Stato degli ebrei”.

E’ arrivato il momento di tentare di fare chiarezza sulle parole, sul loro uso e sulle strumentalizzazioni che s’è ne fanno. Ebrei, giudei, sionisti, semiti, israeliani sono quelle che più si sentono pronunciare da quando, il 7 ottobre, c’è stato l’assalto dei militanti dell’organizzazione palestinese Hamas alle comunità israeliane lungo il confine con la striscia di Gaza.
Sono parole ricorrenti da anni, in molti casi da secoli. Ci interessa soprattutto il periodo che parte dalla fondazione dello Stato di Israele, che Netanyahu ma anche altri leader israeliani considerano e definiscono lo “stato ebraico”, anche se, va ricordato, il venti percento della sua popolazione è formato da non ebrei.
Teoricamente si potrebbe chiamare “stato semita” ma non sarebbe la stessa cosa: gli ebrei ma anche gli arabi, musulmani e non sono, tutti semiti. Per questo, se vogliamo essere precisi, anti-semitismo è un termine che coinvolge sia gli ebrei che gli arabi.
Sono anni che Benjamin Netanyahu porta avanti una campagna molto articolata per convincere il mondo che ogni critica al Israele, soprattutto ai suoi comportamenti nei confronti degli arabi che vivono a Gerusalemme Est e nei territori occupati della Cisgiordania, equivale ad anti-semitismo. Sostiene – e sostengono molte delle organizzazioni ebraiche in Italia e non solo – che non ci sarebbe distinzione tra l’antisemitismo, (chiamato anche giudeofobia; antigiudaismo e antiebraismo) che è il pregiudizio, la paura o l’odio verso gli ebrei e l’antisionismo che esprime la negazione della legittimità dello Stato di Israele. Un miscuglio di termini errati che vogliono far diventare reato qualsivoglia critica allo stato di Israele.
Verso la fine del secolo scorso, quando per la prima volta Netanyahu ascese alla carica di primo ministro di Israele riunì i responsabili dell’hasbara – l’apparato propagandistico del ministero degli Esteri – e spiegò loro come il primo obiettivo del governo israeliano era convincere il mondo che ogni critica a Israele – “allo Stato ebraico”, “allo Stato degli ebrei” – era una forma di anti-semitismo. Negli stessi anni – 1998 – fu fondata quella che sarebbe stata la base dell’IHRA, la International Holocaust Remembrance Alliance.
Secondo la sua dichiarazione fondante, firmata anche dall’Italia, è necessario sostenere la “terribile verità dell’Olocausto contro coloro che la negano” e di preservare la memoria dell’Olocausto come “pietra di paragone nella nostra comprensione della capacità umana per il bene e il male”. “La comunità internazionale – è scritto – condivide la solenne responsabilità di lottare” contro “il genocidio, la pulizia etnica, il razzismo, l’antisemitismo e la xenofobia“.
Non abbiamo assistito a molte lotte della comunità internazionale contro questi fenomeni ancora in atto ma nel 2016, in una riunione a Budapest si volle chiarire cosa poteva essere considerato antisemitismo nel mondo di oggi.
Queste alcune delle considerazioni scritte nel documento ma parzialmente o totalmente contestate:
– Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele, o alle presunte priorità degli ebrei nel mondo, che agli interessi delle proprie nazioni.
– Negare al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, ad esempio affermando che l’esistenza di uno Stato di Israele è uno sforzo razzista.
– Applicando doppi standard richiedendogli un comportamento non previsto o richiesto da qualsiasi altra nazione democratica.
– Utilizzare i simboli e le immagini associate all’antisemitismo classico (ad es. ebrei che uccidono Gesù) per caratterizzare Israele o gli israeliani.
– Facendo paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti.
– Ritenere gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello stato di Israele.”
Qualche anno fa – cinque se ricordo bene – Peter Beinart, professore di giornalismo, scrittore e attivista politico, ebreo in molto cose osservante, figlio di immigrati ebrei dal Sud Africa (suo nonno materno era russo e sua nonna materna, sefardita, egiziana), volle affrontare con un lungo intervento il “mito che anti-sionismo è antisemitismo”.

“La tesi secondo cui l’antisionismo è intrinsecamente antisemita – scrisse in un articolo ripreso recentemente da un giornale inglese – si fonda su tre pilastri. La prima è che opporsi al sionismo è antisemita perché nega agli ebrei ciò di cui gode ogni altro popolo: uno Stato proprio”.
“L’idea che tutti gli altri popoli possano cercare e difendere il proprio diritto all’autodeterminazione ma gli ebrei non possono – ha dichiarato Chuck Schumer nel 2017 – è antisemitismo”.
Come ha affermato l’anno scorso David Harris, capo dell’American Jewish Committee: “Negare al popolo ebraico, tra tutti i popoli della terra, il diritto all’autodeterminazione è sicuramente discriminatorio”.
“Tutti i popoli della terra? – si chiede Beinart -. I curdi non hanno un proprio Stato. Né lo hanno i baschi, i catalani, gli scozzesi, i kashmiri, i tibetani, gli abkhazi, gli osseti, i lombardi, gli igbo, gli oromo, gli uiguri, i tamil, i quebecchesi, né decine di altri popoli che hanno creato movimenti nazionalisti per cercare l’autodeterminazione ma non sono riusciti a raggiungerla”.
“Eppure quasi nessuno suggerisce che opporsi a uno Stato curdo o catalano ti renda un bigotto anti-curdo o anti-catalano. È ampiamente riconosciuto che gli Stati basati sul nazionalismo etnico – stati creati per rappresentare e proteggere un particolare gruppo etnico – non sono l’unico modo legittimo per garantire l’ordine pubblico e la libertà individuale. A volte è meglio promuovere il nazionalismo civico, un nazionalismo costruito attorno ai confini piuttosto che al patrimonio: rendere l’identità spagnola più inclusiva dei catalani o l’identità irachena più inclusiva dei curdi, piuttosto che spartire quegli stati multietnici.”

L’assalto di Hamas alle comunità israeliane ebraiche lungo il confine con Gaza e soprattutto la risposta israeliana ha visto (e continua a generare) parole di odio nei confronti delle comunità ebrei e palestinesi. E in questa situazione il termine anti-semitismo sarebbe perfetto soprattutto se pronunciato da chi, in giro per il mondo, disprezza gli arabi quanto disprezza gli ebrei.
Ragioniamo, con Beinart, sul termine anti-sionisti e anche su stato-coloniale. “Forse – scrive – non è bigotto opporsi alla richiesta di uno stato da parte di un popolo. Ma è bigotto togliere quella statualità una volta raggiunta”.
“Una cosa è sostenere, nella controversa corte dei ‘what-if’ storici, che Israele non doveva nascere – ha affermato l’editorialista del New York Times Bret Stephens. Tuttavia -Israele è ora la patria di quasi 9 milioni di cittadini, con un’identità che è distintamente e orgogliosamente israeliana quanto gli olandesi sono olandesi o i danesi danesi. L’antisionismo propone niente di meno che l’eliminazione di quell’identità e l’espropriazione politica di coloro che la apprezzano”.
“Ma non è bigotto – aggiunge sempre Beinart – cercare di trasformare uno Stato basato sul nazionalismo etnico in uno stato basato sul nazionalismo civico, in cui nessun gruppo etnico gode di privilegi speciali”.

Fino a quando non sarà terminata, o chiarita, la posizione dei coloni ebrei in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, e fino a quando i palestinesi non saranno liberi sulla loro terra, la parola apartheid è considerata da molti un termine valido per definire lo Stato di Israele.
Eric Salerno
eric2sal@yahoo.com
X: @africexp


 Dal Nostro Corrispondente Sportivo
Dal Nostro Corrispondente Sportivo

 Speciale per Africa ExPress
Speciale per Africa ExPress






 Speciale per Africa ExPress
Speciale per Africa ExPress
 Speciale per Africa ExPress
Speciale per Africa ExPress
 Africa ExPress
Africa ExPress




 Speciale per Africa ExPress
Speciale per Africa ExPress
 Africa ExPress
Africa ExPress