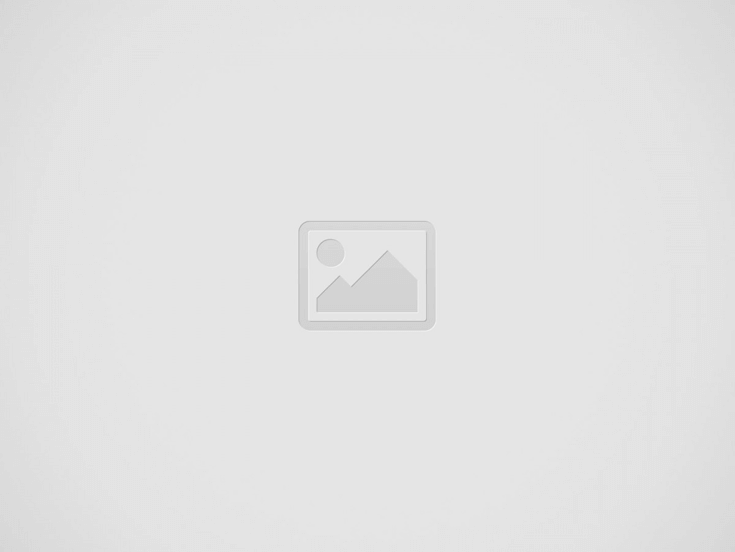

Contingente italiano in Afghanistan
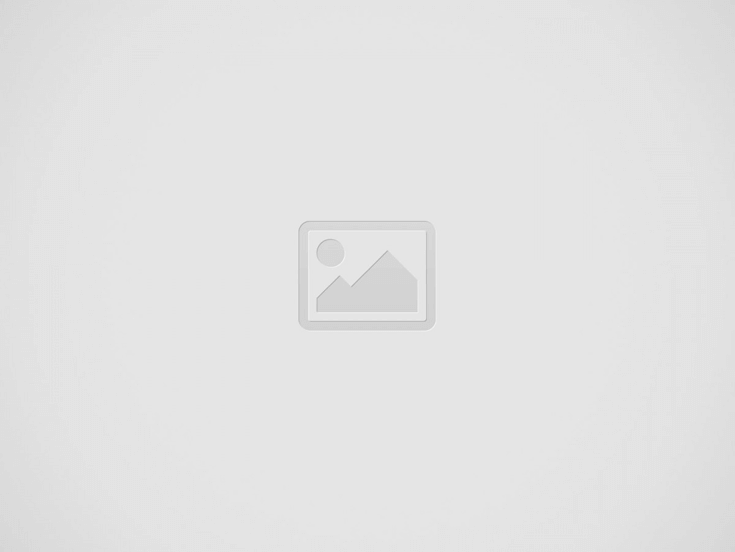

Enzo Polverigiani
28 agosto 2021
A metà del 2013 già si parlava di forte riduzione e poi di conclusione dell’impegno Isaf in Afghanistan. La data di riferimento era fissata al 31 dicembre 2014. A Herat, nel Regional command West affidato agli italiani, le voci si concretizzavano con l’abbandono di basi e avamposti come Farah e Bala Baluk.
Anche gli americani, dal canto loro, si preparavano ad abbandonare la base aerea di Shindad, lasciando equipaggiamenti per milioni di dollari. “Ci costerebbe di più portarceli via – diceva un ufficiale – li lasceremo in dotazione all’esercito afghano”. S’è visto poi com’è andata.
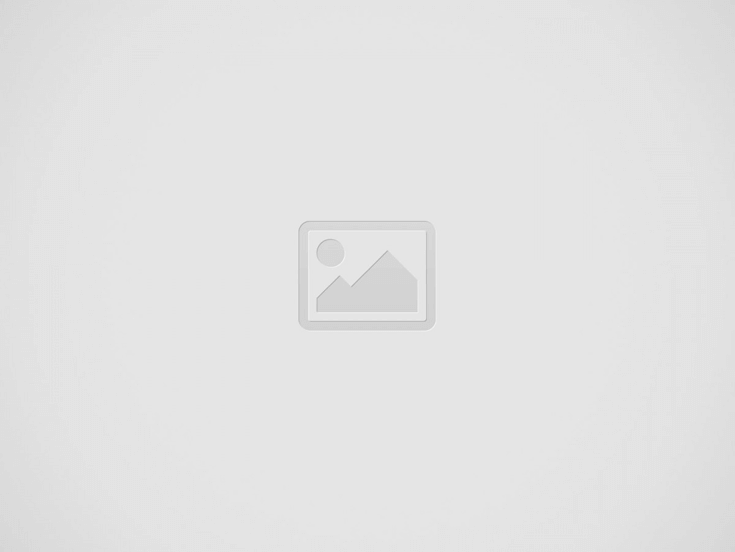

Del clima di parziale smobilitazione risentiva anche una delle strutture. In quegli anni rappresentava più di altre il supporto dell’Italia all’Afghanistan e in futuro, almeno secondo i piani, sarebbe stato il perno della nostra più contenuta presenza in un paese devastato e da reinventare.
Il PRT, Provincial Reconstruction Team, fin dal 2005 aveva finanziato con oltre 40 milioni di euro – stanziati dalla Difesa – progetti e ricostruzioni nella provincia di Herat: una sessantina di scuole, strade e ospedali, carcere, aeroporto, restauro della Moschea blu.
Ma soprattutto aveva agito in ambito sociale, cercando di contrastare la soggezione forzata della donna afghana – di cui il burqa rappresentava il simbolo più radicale – con strutture dedicate, come il Business woman centre, il grande magazzino nel centro di Herat gestito solo da donne. Anche per questo la sede del PRT a Camp Vianini era stata colpita da un drammatico attentato dinamitardo, con cinque militari feriti.
Nell’ufficio di Camp Arena, ultima sede del PRT, c’era il comandante, colonnello Vincenzo Grasso, dotato di humour ma anche rispettoso delle usanze locali. “Il nostro programma è più facile a dirsi che a farsi : sostenere il governo Karzai e rafforzare la fiducia della popolazione nella legalità e nell’autorità locale” spiegava.
“Personalmente – raccontava – tengo i contatti con il presidente della provincia di Herat, Waidi Fasullah, del quale sono amico, e insieme lavoriamo su educazione, sanità, opere idriche e anche fognature. L’acqua, come in tutto l’Afghanistan, è un’emergenza. Ma anche i servizi igienici, per esempio, sono quasi inesistenti. Gli afghani volevano i gabinetti fuori della scuola, e noi siamo riusciti a convincerli che bisognerebbe metterli dentro. Insomma, ci vuole pazienza. E le amicizie giuste sono indispensabili”.
E le donne, le violenze, il burqa? Il colonnello allargava le braccia: “Siamo lontani anni luce da una vera parità dei sessi. Il governo proclama che è ora di dare alle donne maggiori responsabilità, ma fra il dire e il fare…Facciamo il possibile anche sotto l’aspetto sociale, ma occorre tempo, e anche coraggio, per andare contro le tradizioni. La società afghana non vede di buon occhio l’imposizione dall’esterno di forme di emancipazione e democrazia. Tuttavia, qui a Herat ho visto la gioia negli occhi dei bambini di una scuola. Sono centinaia, nel cortile c’è anche la tenda dell’Unicef. Uno spettacolo che allarga il cuore e che fino all’altro ieri non era possibile. Un messaggio di speranza”.
Siamo andati a verificare questo messaggio con il colonnello, a bordo di gipponi Toyota bianchi, anonimi ma molto blindati. I più grintosi Lince darebbero ai civili “un segnale di occupazione” inopportuno. Finestrini serrati, i suv procedono veloci in fila indiana e impediscono con rapide manovre l’inserimento di altre auto nel convoglio.
Il centro di Herat è tutto un vociante e strombazzante bazar in movimento, spiccano turbanti scuri e shalwar, gli abiti tradizionali degli uomini e i burqa celesti o i meno estremi hijab bianchi – i veli – dei gruppi di donne con in braccio i bambini. Ecco le famigerate Corolla bianche, le auto preferite dai terroristi.
“Ce ne saranno diecimila a Herat, quale sarà quella giusta?” ironizzava il caposcorta. Insomma, un fiume di veicoli di ogni tipo da scrutare con occhio allenato per individuare il più piccolo segnale di pericolo. Così erano costretti a muoversi, nelle città afghane, gli uomini dell’Isaf ormai a fine missione di pace: con i nervi tesi, le armi in pugno e il dito sul grilletto.
Ecco la scuola, in una stradina, con accanto il cantiere di una seconda palazzina finanziata dal PRT. E c’era tutto ciò che ci aveva promesso il colonnello. Le scolarette erano in divisa: abito nero e il viso, quasi sempre bellissimo, incorniciato dal velo bianco.
Si coprivano gli occhi scuri e ammiccanti, ma poi la curiosità era più forte e davano una sbirciata agli sconosciuti, per nascondersi subito dietro il velo con risatine soffocate. Anche le insegnanti, belle ragazze con un’ombra di trucco, erano velate come la direttrice Sina Shaidxar, che spiegava: “Questa è una scuola quasi interamente femminile, con migliaia di bambine. E una donna senza educazione non può essere mamma di figli che dovranno servire la patria. Intanto ringrazio l’Italia, ancora una volta, ma ora è fondamentale riuscire a essere autosufficienti. Anche se mi auguro che gli italiani, quando lasceranno la loro missione, continuino a collaborare con noi”.
All’Università della Repubblica islamica dell’Afghanistan, facoltà di giornalismo, le prime parole del preside Nimatullah Sarwari sono di circostanza, ma poi si riempiono di amarezza e sconforto. “Afghanistan e Italia hanno molti aspetti in comune. Noi con il PRT abbiamo un ottimo rapporto, che speriamo prosegua anche dopo. Ma la sicurezza e i diritti umani sono gravemente compromessi. Negli ultimi vent’ anni, nel mio Paese, sono stati uccisi ventisette giornalisti tra cui, nel 2001, la vostra Maria Grazia Cutuli. Eravamo certi che le autorità avrebbero investigato su queste morti, e invece è sempre buio fitto. La guerra non offre alcuna soluzione: non abbiamo bisogno di eserciti, ma di cultura, di istruzione, e i giornalisti possono fare molto. Dobbiamo motivarli, mandarli nei villaggi a diffondere notizie vere. Vorremmo che qualche nostro giornalista venisse in Italia, a imparare. Vedete questi ragazzi e ragazze? La loro sola ambizione è di lavorare, ma la situazione occupazionale non è buona. Qui purtroppo non c’è mercato”.
Avevamo voglia di dirgli “anche noi, su questo punto, non siamo messi bene”, ma l’abbiamo lasciato concludere: “Questo è un paese colpito da una secolare fatwa, una maledizione, e frammentato in più parti tra le aree tribali incontrollabili, l’area di Kabul col governo Karzai a sovranità limitata, preda della corruzione più sfrenata, e il sud sempre in bilico politicamente e in mano ai contrabbandieri e ai signori della droga. Qualcuno ha paragonato la situazione afghana al tradizionale gioco del buzkashì, in cui i cavalieri si disputano selvaggiamente la carcassa di una capra senza testa: metafora perfetta dell’Afghanistan”.
Oggi il ministro Di Maio promette, nella retorica dell’ufficialità, di non abbandonare le donne e le ragazze afghane al loro destino. Ma già allora, a metà della missione Isaf, si era fatto poco o nulla: l’Afghanistan era ancora sprofondato nel Medioevo, a eccezione di qualche faticoso spiraglio di modernità. Perciò era diffuso il timore di un nuovo salto nel buio, di un giro di vite integralista, di un ritorno alla tradizione più ferocemente maschilista una volta partiti i soldati dell’Isaf e rientrati i talebani nel governo, come si prospettava. Anche per questo molte donne afghane non abbandonavano il burqa. Un po’ per fedeltà alle tradizioni, e molto per la paura del futuro.
Dunque, la strada verso i pieni diritti era ancora lunga, ma un messaggio di speranza ci veniva consegnato da Nahid Ahmad, fiera di non portare il velo come le colleghe. Bellissimi occhi scuri e bistrati, atteggiamento spigliato, minigonna altrettanto disinvolta, affermava con sicurezza: “Meno di dieci anni fa le donne in Afghanistan erano trattate come schiave. Non potevano studiare all’università, erano schiacciate sotto il tallone dello spietato fanatismo dei talebani. Venivano uccise dai loro stessi mariti e fratelli per un niente. In questi ultimi anni le donne hanno ottenuto più diritti, possono esprimersi quasi liberamente e possono essere parte attiva della comunità. Naturalmente accadono ancora cose orribili tra le mura domestiche, ma ora le donne afghane non sono più disposte a tornare indietro. Spero tanto che la politica non subisca un’involuzione autoritaria”.
Un paradosso dalle alte mura era il carcere: per molte giovani donne rappresentava un mezzo per sfuggire ai maltrattamenti e alle violenze domestiche. Spose forzate ancora bambine, o scappate per evitare quel destino; costrette a nascondersi sotto il burqa per “non indurre in tentazione”; minacciate, seviziate, imprigionate soltanto per “aver pensato all’adulterio”, oppure, ed è sbalorditivo, per aver “subito uno stupro”. Ridotte schiave, vendute per acquistare cibo, le donne afghane, molto spesso, sono esasperate fino all’omicidio.
Questo penitenziario-rifugio-albergo, allora diretto dal generale Sadegi, si trovava al centro di Herat, costruito su progetto del PRT con finanziamento della Difesa e dell’Unione Europea, e ospitava circa duecento donne e settanta bambini che vivevano con le madri. La maggior parte accusate di prostituzione, e anche di omicidio, sequestro e favoreggiamento, in questi casi complici di bande criminali. Ma perfino il generale, robusto, baffuto e paternalista, esprimeva le sue attenuanti generiche: “Per i talebani e gli integralisti islamici la donna non esiste”. C’era da crederci, se lo diceva lui.
Sembrava, più che un carcere, una scuola di formazione con sala internet, reparto di estetista, sartoria; solo l’ombra delle inferriate, disegnata sui tappeti consunti e sulla moquette strappata via, riportava alla realtà. Queste detenute anomale guarnivano camicie con i suzani, i ricami tagiki, imparavano a truccare occhi e bocche, navigavano in rete mentre i bambini, in un’altra sala, erano intenti ai loro giochi chiassosi e si raggruppavano, con curiosità, intorno ai visitatori.
Abiti e oggetti d’artigianato erano esposti in una stanza. Dai veli delle donne radunate in crocchi emergevano bei visi olivastri, grandi occhi sgranati, piercing tradizionali e complicati, pesanti orecchini d’argento “povero” con monete e conchiglie incastonate.
Più che guardare al passato, quelle donne e ragazze erano protese verso il futuro. Semplici frasi svelavano progetti, intenzioni, desideri profondi. Nasime, per esempio, raccontava di aver subito, nella sua casa, violenze continue da un marito sposato a forza, ma diceva che prima o poi sarebbe tornata al villaggio.
Non voleva andarsene all’estero? “No, perché questo è il mio Paese, ho ancora fiducia in un cambiamento”. Se si pensa a quello che sta accadendo in Afghanistan, sette anni dopo, quelle parole fanno ancora più male.
Enzo Polverigiani
enzo.polve@gmail.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Africa ExPress pubblica opinioni provenienti da una vasta gamma di prospettive al fine di promuovere…
Dal Nostro Corrispondente Sportivo Costantino Muscau 23 aprile 2025 John Korir sedeva ancora sui banchi…
Speciale per Africa ExPress Cornelia I. Toelgyes 22 aprile 2025 L’Africa piange Papa Francesco. E…
Dalla Nostra Vaticanista Emanuela Provera 21 aprile 2025 The English version is here Nato nel…
From Our Vatican Correspondent Emanuela Provera April 21, 2025 La versione in italiano si trova…
EDITORIALE Massimo A. Alberizzi Milano, 18 aprile 2025 Da un po' di tempo continua ad…