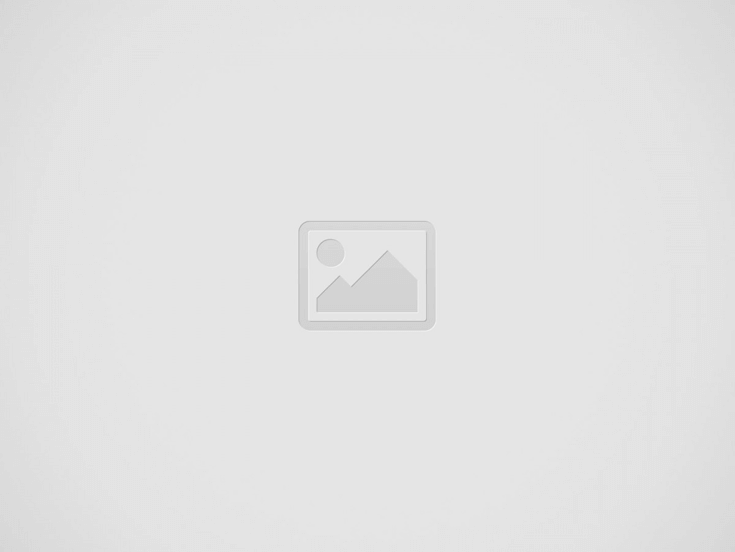

Maman Abou, giornalista nigerino
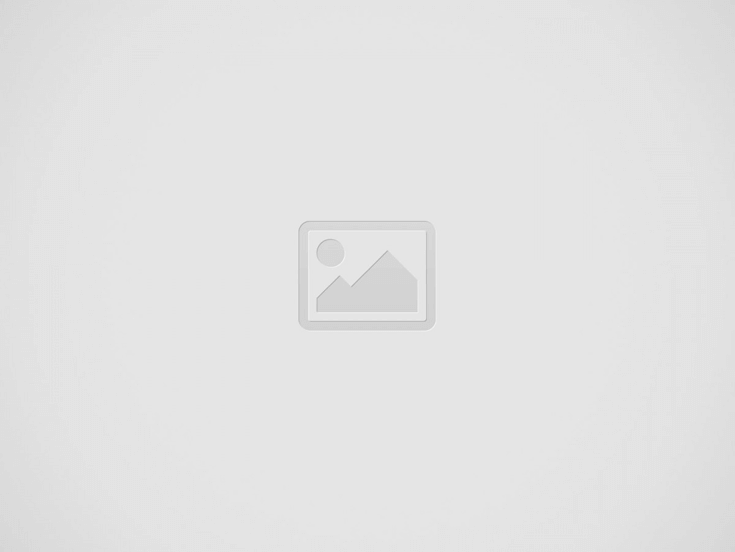

Massimo A. Alberizzi
15 luglio 2020
Colpito un paio d’anni fa da un ictus dal quale non si era mai più ripreso è morto a Niamey, capitale del Niger, Mamane Abou, il giornalista che aveva rivoluzionato la stampa e l’editoria nel suo Paese. Pur essendo membro del partito al potere dalle pagine del suo giornale Le Républicain non disdegnava pesanti critiche al governo e all’establishment, accusato di corruzione e distrazione di fondi pubblici.
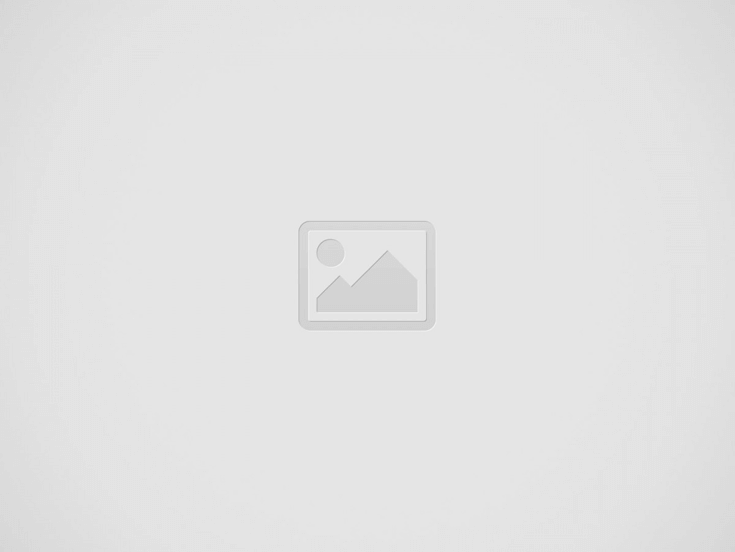

Di nazionalità tuareg attaccava spesso la sua tribù che accusava di perpetrare ancora la vecchia e disumana pratica ancestrale dello schiavismo.
In questa veste mi ha aiutato molto, quando ho visitato il Niger i villaggi sahariani alla ricerca di uno schiavo o di una schiava da comprare e liberare. Mi aveva procurato i contatti per entrare al mercato clandestino dei dannati a Tchintabaraden, un villaggio del Niger centrale.
Gli articoli che ho scritto allora li ripubblichiamo di nuovo qui e li dedico al mio amico Maman Abou, a ricordo della sua lotta per l’emancipazione dei più poveri e diseredati.
Massimo A. Alberizzi
massimo.alberizzi@gmail.com
Massimo A. Alberizzi
Abalak (Niger centrale), 23 agosto 2005
Le donne vestite di nero, con la pelle scurissima e il volto incorniciato da un paio di orecchini e da una collanina d’oro, si avvicinano all’auto sorridenti. Vogliono vendere panetti di formaggio di capra. L’autista, Addu, ne è goloso e ne acquista un paio. “Queste sono le schiave dei tuareg – spiega –. Il ricavato di ciò che vendono finisce direttamente nelle tasche dei loro padroni che le ricompenserà con un paio di pugni di miglio in più”.
Il marabù è il gran sacerdote che da queste parti ha saputo coniugare i precetti dell’islam con quelli delle più antiche tradizioni animiste africane. Il risultato è strabiliante: all’inizio del terzo millennio, giocando sulla superstizione, sui tabù e sulle disgrazie umane, il marabù riesce a far credere agli schiavi che la loro condizione è una benedizione di Dio e quindi va accettata perché non durerà in eterno: chi si rassegna alla volontà di Allah, alla fine verrà ricompensato, dopo la morte, con il paradiso. Quello sì che durerà in eterno! Chi si ribella in vita, invece sarà punito e andrà all’inferno.
Ma il vero inferno, per gli schiavi, intanto è quaggiù. La loro vita è crudele e scandita dall’obbedienza e dal lavor
I marabù, naturalmente, sono quelli che posseggono il maggior numero di schiavi. I padroni, pelle bianca, hanno nomi arabi; gli schiavi, pelle nerissima, come il carbone, nomi africani. Ma ci sono anche padroni della pelle nera e dai nomi africani che comandano neri come loro.
In Niger è rimasta soltanto la schiavitù ereditaria e per via materna. Formalmente anche quella è vietata dalla legge; sostanzialmente i bellà (o taklit, come vengono chiamati a seconda delle tribù) vivono in condizioni di plagio psicologico che si può riassumere così: “Siamo nati per servire e moriremo servitori”, nella fanatica convinzione di andare in paradiso dopo la morte.
Weila Ilguilas è il presidente dell’organizzazione Timidria (“Solidarietà e fraternità” in tamashek, la lingua tuareg) che dal 1991, lotta contro la schiavitù in Niger. Timidria, riconosciuta da Anti-Slavery International, è assai critica con il governo del Niger e con il suo presidente Mamadou Tandja (uno dei pochi eletti democraticamente in Africa): “Combatte lo schiavismo solo a parole, in realtà non solo lo tollera, ma non favorisce le pratiche per abolirlo e liberare chi è senza libertà, spiega Weila.
In febbraio scorso Weilà è stato messo in carcere per 48 giorni, accusato di aver distratto i fondi della sua organizzazione. “Tutto falso. Volevano solo intimidirci. Infatti le accuse sono cadute e mi hanno liberato senza processo”. Poi mostra una lettera che sarebbe all’origine dell’arresto. La scrive Arrissak Amdagh, capo tuareg del raggruppamento nomade di Tahabanatt. Su carta intestata “Repubblica del Niger – Regione di Tillabery”, datata 28 settembre 2004, il leader tribale annuncia ”la decisione solenne di abolire ufficialmente tutte le pratiche di schiavitù, come sancito dalla legge” e quindi di liberare “più di 7000 persone considerate come schiave”.
Naturalmente la grande cerimonia programmata per la liberazione il 25 febbraio è stata annullata e i 7000 disgraziati sono rimasti ancora sotto il loro padrone.
Maman Abou è figlio del capo tuareg di una potente tribù che vive vicino a Niamey dirige il giornale progressista e antigovernativo Le Républicain: “Mio padre aveva un numero enorme di schiavi, uomini donne bambini”, racconta. Duecento? “No, no, molti di più. Ma facevano parte della famiglia. Noi, figli del padrone, giocavamo con loro e con i loro figli, che venivano a scuola con noi. Mio padre ha creato le condizioni perché potessero essere affrancati, ha cominciato a pagar loro un salario, a permettergli il possesso delle loro cose e infine ha loro detto:’ se volete potete andare via’. Pochi se ne sono andati. Ma la seconda generazione, cioè i loro figli hanno quasi trovato una propria strada e se ancora lavorano per la mia famiglia sono pagati, hanno le loro case e non devono scattare a ogni ordine. Soprattutto non hanno più paura di diventare una capra”. Ride Maman Abou, ma non tutte le famiglie tuareg sono come la sua.
E’ vero non esiste più il mercato pubblico degli schiavi, ma il loro commercio è ancora vivo anche se clandestino. Vengono regalati o venduti sottobanco e nella loro vita possono passare da un padrone all’altro. Le famiglie dei signori, gli imijighane, i ricchi, i nobili che vengono prima solo dei marabù, riconoscono e disprezzano chi appartiene alla classe “ inferiore e negletta” degli schiavi.
Nei villaggi del Niger colpiti dalla carestia, il cibo sta pian piano arrivando, grazie agli sforzi del World Food Programme, l’agenzia dell’Onu che opera nelle aree più disastrate del pianeta. Un sacco o due a famiglia, utili per sfamare i padroni. Nulla è previsto per gli schiavi. Per loro restano solo le briciole.
Massimo A. Alberizzi
massimo.alberizzi@gmail.com
twitter @malberizzi
Le foto sono di Massimo A. Alberizzi
Dal nostro inviato
Massimo A. Alberizzi
Tchintabaraden (Niger), 29 Giugno 2004
“No, signore. Io sono una taklit, una schiava. Non posso venire via con te. Appartengo al mio padrone”. Ma chi è il tuo padrone? “Si chiama Mussa ed è capo villaggio a Garò. E’ lui che decide dove posso andare”. Altana Algamis dice di avere 35 anni. I suoi occhi sono neri come il carbone e penetranti come una spada. La incontro davanti a un pozzo, a un’ottantina di chilometri da Tchintabaraden, un villaggio tuareg in Niger, arrostito dal sole, nella cintura semidesertica del Sahara meridionale.
Le altre donne, colpite da quella conversazione, si avvicinano, scoppiano a ridere perché non capiscono di cosa stia parlando quello straniero che ha la pelle bianca (ma loro dicono rossa) identica a quella dei loro padroni. Altana, hai un marito? “Sì, certo. Si chiama Wassididan ed è schiavo anche lui. Alleva gli animali del nostro maître”. Chi ha deciso che dovevate sposarvi? I vostri genitori? Altana scoppia in una risata. “Il padrone, naturalmente. E’ lui che ha stabilito anche la dote”. Beh, allora ti ha dato qualcosa. “Sì. Ha disposto una dote di 4 capre”. Che vi siete spartite tu e Wassididan? “No, noi non possiamo possedere nulla. Tutto quello che abbiamo appartiene al padrone”. Quindi anche le capre! “Certo. Infatti dopo avercele date, se l’è riprese”.
E la collanina di perline che hai al collo? E gli orecchini? “Me li ha regalati il padrone, ma sono suoi”. E i due figli Al Kassan e Agali? “Sono grandi ormai. Non so bene dove siano finiti. Probabilmente in Libia”. Sono scappati o sono stati venduti? “Non lo so”. Cos’è la Libia? “Qualcosa che è lì, oltre l’orizzonte. Li aspetto perché un giorno torneranno”.
“Allora vieni con noi”, incalza Amaloz. E lei scuotendo la testa, spaventata, preoccupata e abbandonando il suo cordiale sorriso: “Io conosco solo questo posto. Se mi allontano avrò sicuramente grandi problemi. Il marabù mi ha detto che non posso lasciare il padrone altrimenti potrei morire o essere trasformata in animale. Io non voglio diventare una capra”!
Il marabù è il gran sacerdote del villaggio. Una sorta di imam musulmano che ha “ereditato” i poteri magici dalla stregoneria animista africana, più efficaci, da queste parti, di quelli del Profeta. E’ lui che considera gli schiavi una benedizione di Dio e che, così, ne giustifica l’esistenza. I marabù, in effetti, sono quelli che posseggono il maggior numero di schiavi.
Loro e la loro famiglia non fanno nulla. Non muovono un dito. Esercitano solo il potere assoluto su una moltitudine di poveracci che dipendono in tutto e per tutto da loro: donne che percorrono chilometri e chilometri nel deserto infuocato di sabbia per raggiungere un pozzo, caricare gli otri d’acqua, tornare a casa e poi rigovernare e cucinare; uomini che badano agli animali, raccolgono la legna, montano e smontano tende e capanne durante le migrazioni dei padroni nomadi.
Aljaoudat ha 25 anni. Seduta su un asino traballante sta portando a casa gli otri stracolmi d’acqua. All’inizio nega di essere una schiava ma viene tradita dagli abiti, neri, e dai monili fatti con perline colorate. Sembra quasi un’uniforme quella che indossano le donne senza libertà, ben diversa dai multicolori vestiti e dagli orecchini e collane d’oro o d’argento delle loro padrone.
Così Aljaoudat racconta la sua vita. “Sono nata schiava e Dio mi ha creato per questo. Quando avrò finito questa vita, finalmente raggiungerò il paradiso che mi è stato promesso. I miei genitori erano schiavi di Muala Mugaiala, il mio padrone che ora comanda su 200 persone: 100 uomini, 50 donne e 50 ragazzi. Sai, è una persona importante – aggiunge senza nascondere una punta d’orgoglio -. Lui va sempre a Niamey a parlare con i ‘capi’”.
Aljaoudat non ha mai visto una televisione e non sa bene cosa sia l’energia elettrica. In compenso sa accendere uno scoppiettante fuoco sbattendo per meno di mezzo minuto due pezzi di selce.
Ma com’è la tua vita? “Mi alzo prima dell’alba e preparo il the e la colazione per il padrone le sue due mogli e i loro figli. Poi vengo al pozzo e ci metto parecchio tempo”. Quante ore? “Cos’è l’ora?”. Va bene continua. “Quindi torno a casa e cucino, spazzo le tende in continuazione perché sabbia e polvere qui entrano dappertutto. Per tutto il giorno, ma anche la notte, eseguo gli ordini dei miei padroni. Scatto appena mi chiamano e questo può accadere in qualunque momento”.
E se non scatti? “La punizione può essere terribile. Abdullahi mi picchia o mi lascia senza mangiare o mi fa accoppiare con un uomo diverse volte in un giorno. Sono sommersa poi dagli insulti, anche se non disubbidisco”. Hai mai pensato di scappare? “E perché mai? Io eseguo solo la volontà di Dio. Certo mi pesa un po’, però prima o poi finirà”.
Weila Ilguilas è il presidente dell’organizzazione Timidria (“solidarietà in lingua tamashek), che lotta contro la schiavitù in Niger : “I padroni – spiega – hanno tutti nomi islamici Mohammed, innanzitutto, Ali, Abdulkadir e così via. Gli schiavi nomi africani. Quando un bimbo nasce in schiavitù è il proprietario del padre che gli dà il nome che, quindi, non può accettare che si chiami come il proprio figlio”.
Timidria – nata nel 1991 e riconosciuta da Antislavery International, con sede a Londra – ha calcolato che in Niger vivano 870 mila schiavi su una popolazione di 11 milioni d’abitanti. Tutte le più grandi tribù la esercitano (i tuareg, i djermà, i poel) tranne gli hausa. La pratica è vietata dalla legge.
L’ultimo di una lunga serie di decreti – tutti per altro il gran parte inapplicati – che puniscono chi se ne serve è stato promulgato il 7 aprile scorso. “Non basta una legge per abolire la schiavitù – aggiunge Weilà -. Occorre creare le condizioni economiche perché gli schiavi possano diventare liberi. Oggi il loro padrone è per loro una protezione: mangiano tre volte al giorno e questo ai loro occhi giustifica maltrattamenti e angherie”.
“Oggi non si deve pensare che gli schiavi siano tenuti incatenati con ceppi e ferri – chiarisce Weilà -. Lo schiavismo, piuttosto, è un atteggiamento mentale, congeniale agli interessi dei proprietari. Il governo non fa nulla per affrancarli perché i suoi membri sono i primi a servirsene. Le loro case sono piene di servitori e di famigli che non ricevono alcun salario e debbono solo obbedire agli ordini. Non esiste più il mercato degli schiavi ma il loro commercio è ancora vivo anche se clandestino. Vengono regalati o venduti sottobanco e nella loro vita possono passare da un padrone all’altro. A questi esseri che vivono in uno stato subumano vien fatto credere che Dio li abbia creati solo per servire. Appartengono a una casta dalla quale non si può uscire neppure una volta riacquistata la libertà. Le famiglie dei padroni, gli imijighane, i ricchi, i nobili che vengono prima solo dei marabù, riconoscono e disprezzano chi appartiene alla classe “ inferiore e negletta” degli schiavi. E’ una forma ignobile di razzismo e per giustificarla si chiama in causa Allah, che, invece, non c’entra proprio nulla. Occorre dire basta a questa ignobile pratica. Non è concepibile che mentre l’uomo va sulla luna, qui ci sia ancora gente costretta alla schiavitù”.
Massimo A. Alberizzi
massimo.alberizzi@gmail.com
twitter @malberizzi
Le foto di questo gruppo di schiavi sono di Massimo A Alberizzi. La seconda è il ritratto di Altana Algamis
Africa ExPress New York, 14 marzo 2025 Guerre, conflitti interni, terrorismo, cambiamenti climatici, persecuzioni e…
Speciale per Africa ExPress Cornelia I. Toelgyes 11 marzo 2025 In Sud Sudan, il fragile…
Speciale per Africa ExPress Massimo A. Alberizzi 10 marzo 2025 Se la cosa non fosse…
Speciale per Africa ExPress Cornelia I. Toelgyes 8 marzo 2025 “Stiamo dando 8 milioni di…
Speciale per Africa ExPress Sandro Pintus 7 marzo 2025 Nella tarda mattinata del 5 marzo…
Speciale per Africa ExPress Federica Iezzi 6 marzo 2025 Bloccato l'ingresso di cibo, acqua, materiale…